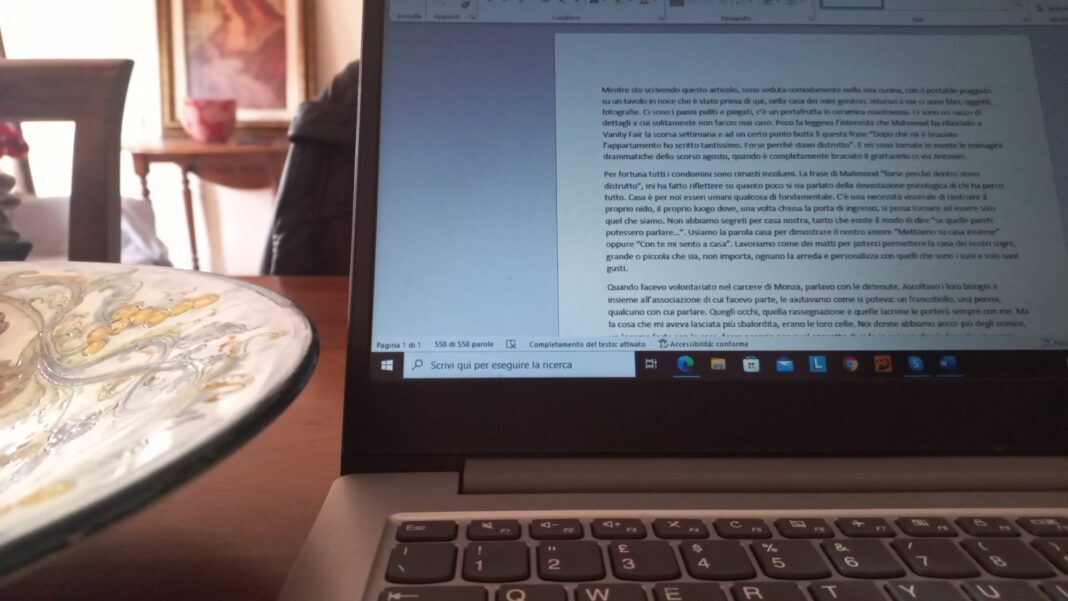Mentre sto scrivendo questo articolo, sono seduta comodamente nella mia cucina, con il portatile poggiato su un tavolo in noce che è stato prima di qui, nella casa dei miei genitori.
Intorno a me ci sono libri, oggetti, fotografie. Ci sono i panni puliti e piegati, c’è un portafrutta in ceramica mantovana. Ci sono un sacco di dettagli a cui solitamente non faccio mai caso.
Poco fa leggevo l’intervista che Mahmood ha rilasciato a Vanity Fair la scorsa settimana e ad un certo punto butta lì questa frase “Dopo che mi è bruciato l’appartamento ho scritto tantissimo. Forse perché stavo distrutto”. E mi sono tornate in mente le immagini drammatiche dello scorso agosto, quando è completamente bruciato il grattacielo in via Antonini.
Per fortuna tutti i condomini sono rimasti incolumi. La frase di Mahmood “forse perché dentro stavo distrutto”, mi ha fatto riflettere su quanto poco si sia parlato della devastazione psicologica di chi ha perso tutto.
Casa è per noi esseri umani qualcosa di fondamentale. C’è una necessità viscerale di costruire il proprio nido, il proprio luogo dove, una volta chiusa la porta di ingresso, si possa tornare ad essere solo quel che siamo. Non abbiamo segreti per casa nostra, tanto che esiste il modo di dire “se quelle pareti potessero parlare…”.
Usiamo la parola casa per dimostrare il nostro amore “Mettiamo su casa insieme” oppure “Con te mi sento a casa”. Lavoriamo come dei matti per poterci permettere la casa dei nostri sogni, grande o piccola che sia, non importa, ognuno la arreda e personalizza con quelli che sono i suoi e solo suoi gusti.
Quando facevo volontariato nel carcere di Monza, parlavo con le detenute. Ascoltavo i loro bisogni e insieme all’associazione di cui facevo parte, le aiutavamo come si poteva: un francobollo, una penna, qualcuno con cui parlare. Quegli occhi, quella rassegnazione e quelle lacrime le porterò sempre con me.
Ma la cosa che mi aveva lasciata più sbalordita, erano le loro celle. Noi donne abbiamo ancor più degli uomini, un legame forte con la casa, forse proprio per quel concetto di nido in cui accudire la famiglia. In queste celle, donne provenienti da paesi e culture diverse, mettevano foto di giornali o disegni appesi ai muri, come fossero quadri. Appendevano tessuti o carta alla finestrella, per fare le tende. Alla luce sul soffitto, spesso attaccavano lavoretti fatti con carta o cartone, per rendere quella lampadina più simile ad un lampadario. Il bisogno anche per loro di sentirsi a casa in uno spazio minuscolo e condiviso era fondamentale.
Una casa per i rifugiati ucraini
In questi giorni stiamo assistendo ad immagini inimmaginabili fino a dieci giorni fa. Persone come noi che avevano una casa, un lavoro, una vita normalissima, stanno scappando da casa loro. Moltissimi l’hanno persa per sempre, insieme a tutti i ricordi, i mobili, gli abiti…
Non hanno più nulla. Molti di loro sono già arrivati qui a Milano e continueranno a farlo. Chi vuole può decidere di ospitarne nella propria casa. Questo nostro spazio così privato ed intimo, potrebbe diventare per i rifugiati ucraini un luogo dove sentirsi più protetti. Potrebbe diventare per chi ospita, un arricchimento importante. Un gesto come questo ci ricorderebbe il significato di “essere umano”.
Per informazioni stranieri@caritasambrosiana.it oppure 02.40703424. Nella mail indicare nome e cognome, numero di telefonico, indirizzo, quante persone possono essere ospitate e per quanto tempo ed eventuali costi. Grazie.